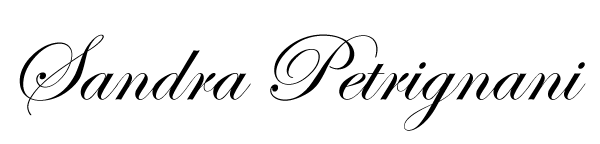Esperienze sessuali del terzo tipo (da “Poche storie”)
 La vita è distante, un gomitolo annodato stretto con i fili che si incrociano come le strade del mondo. La mia vita è stata lunga, movimentata, appassionata, anche se adesso la rivedo tutta chiusa in un solo punto con gli avvenimenti e gli anni e le storie senza svolgimento, quasi fossero proiettate su uno schermo fisso e accadute tutte nel medesimo istante. Devo compiere un’operazione di avvicinamento, di messa a fuoco, una forzatura della memoria e dell’attenzione per ricordare sul serio. E voglio ricordare sul serio, voglio ricordarmi di lei che adesso ‑ecco la vedo bene ‑ sta sulla sdraio con il libro abbandonato in grembo e lo sguardo perso a pensare a me. Non mi dimentica, no, la mia signora e padrona, la mia adorata, l’unico essere umano che ho amato. Sta immaginando che io attraverso il prato con l’andatura elegante della giovinezza, immagina che mi fermi richiamata dal suo sguardo e che anch’io la guardi col mio sguardo più altero e più innamorato. Siamo state insieme sedici anni e sei mesi, amandoci furiosamente, teneramente, estaticamente. Lei in me amava soprattutto la bellezza. Io non posso dire con altrettanta sicurezza cosa fu a conquistarmi subito, io ero fatta cosí: ero nata per una passione esclusiva e questa passione era lei. Che eravamo destinate l’una all’altra l’abbiamo capito immediatamente al primo incrociarsi dei nostri occhi, neri come petali di velluto di un fiore inesistente i suoi, azzurri come tonde acquamarine i miei. Avevo cinque mesi, la pelliccia color champagne e la testa estremamente ben fatta, ma i miei occhi, larghi e preziosi, cristallini e fondi come specchi, screziati di celesti cieli e di celesti laghi, luminosi come diamanti purissimi, circondati dal nero bordo delle palpebre come fossi un’antica divinità egizia, tagliati dal nero ago della pupilla, l’hanno catturata in una malia infinita che non si esaurisce nemmeno ora, ora che non ho più corpo visibile. Non mi sono comportata benissimo in quella prima occasione. Mi era stato annodato un fiocco intorno alla gola, ero stata sbattuta in un cesto soffocante e sballottata nella mia nuova casa senza delicatezza. Sentii la sua voce che protestava, che diceva preferisco i cani, non voglio gatti. Parlava di un cucciolo che le era morto, ma la sua voce era dolce, mi piacque. Finalmente fui tirata fuori e mi vide e io vidi lei. Non parlò più del cane, mi accarezzò e rimase abbagliata dai miei occhi. Anche io dai suoi, così buoni e così belli, così sensibili e così brillanti. Ebbi paura che mi rifiutasse e allora sono scappata e mi sono nascosta in un buco irraggiungibile. Ci sono stata, immobile, tre giorni, fingendo di non capire che quel nome prezioso che lei gridava per farmi uscire, Topazia, era il mio, il nome da lei deciso per me in sostituzione del melenso Susi che avevo portato controvoglia fino a quel momento. Topazia mi sembrò degno della gatta regale che ero. Decisamente lei era la donna della mia vita. E testarda anche, voleva spuntarla, voleva che l’amassi come già lei mi amava. Fu felice quando uscii dal nascondiglio. Mi sono ravviata velocemente il pelo e le ho detto miao più di una volta. Così è cominciata la nostra storia fatta di separazioni dolorosissime ‑ soprattutto per me, ho il sospetto ‑ e meravigliose vicinanze, compagnie lunghe e affettuose, scherzose e privatissime. E di un costante, necessario, contatto fisico.
La vita è distante, un gomitolo annodato stretto con i fili che si incrociano come le strade del mondo. La mia vita è stata lunga, movimentata, appassionata, anche se adesso la rivedo tutta chiusa in un solo punto con gli avvenimenti e gli anni e le storie senza svolgimento, quasi fossero proiettate su uno schermo fisso e accadute tutte nel medesimo istante. Devo compiere un’operazione di avvicinamento, di messa a fuoco, una forzatura della memoria e dell’attenzione per ricordare sul serio. E voglio ricordare sul serio, voglio ricordarmi di lei che adesso ‑ecco la vedo bene ‑ sta sulla sdraio con il libro abbandonato in grembo e lo sguardo perso a pensare a me. Non mi dimentica, no, la mia signora e padrona, la mia adorata, l’unico essere umano che ho amato. Sta immaginando che io attraverso il prato con l’andatura elegante della giovinezza, immagina che mi fermi richiamata dal suo sguardo e che anch’io la guardi col mio sguardo più altero e più innamorato. Siamo state insieme sedici anni e sei mesi, amandoci furiosamente, teneramente, estaticamente. Lei in me amava soprattutto la bellezza. Io non posso dire con altrettanta sicurezza cosa fu a conquistarmi subito, io ero fatta cosí: ero nata per una passione esclusiva e questa passione era lei. Che eravamo destinate l’una all’altra l’abbiamo capito immediatamente al primo incrociarsi dei nostri occhi, neri come petali di velluto di un fiore inesistente i suoi, azzurri come tonde acquamarine i miei. Avevo cinque mesi, la pelliccia color champagne e la testa estremamente ben fatta, ma i miei occhi, larghi e preziosi, cristallini e fondi come specchi, screziati di celesti cieli e di celesti laghi, luminosi come diamanti purissimi, circondati dal nero bordo delle palpebre come fossi un’antica divinità egizia, tagliati dal nero ago della pupilla, l’hanno catturata in una malia infinita che non si esaurisce nemmeno ora, ora che non ho più corpo visibile. Non mi sono comportata benissimo in quella prima occasione. Mi era stato annodato un fiocco intorno alla gola, ero stata sbattuta in un cesto soffocante e sballottata nella mia nuova casa senza delicatezza. Sentii la sua voce che protestava, che diceva preferisco i cani, non voglio gatti. Parlava di un cucciolo che le era morto, ma la sua voce era dolce, mi piacque. Finalmente fui tirata fuori e mi vide e io vidi lei. Non parlò più del cane, mi accarezzò e rimase abbagliata dai miei occhi. Anche io dai suoi, così buoni e così belli, così sensibili e così brillanti. Ebbi paura che mi rifiutasse e allora sono scappata e mi sono nascosta in un buco irraggiungibile. Ci sono stata, immobile, tre giorni, fingendo di non capire che quel nome prezioso che lei gridava per farmi uscire, Topazia, era il mio, il nome da lei deciso per me in sostituzione del melenso Susi che avevo portato controvoglia fino a quel momento. Topazia mi sembrò degno della gatta regale che ero. Decisamente lei era la donna della mia vita. E testarda anche, voleva spuntarla, voleva che l’amassi come già lei mi amava. Fu felice quando uscii dal nascondiglio. Mi sono ravviata velocemente il pelo e le ho detto miao più di una volta. Così è cominciata la nostra storia fatta di separazioni dolorosissime ‑ soprattutto per me, ho il sospetto ‑ e meravigliose vicinanze, compagnie lunghe e affettuose, scherzose e privatissime. E di un costante, necessario, contatto fisico.
Siamo arrivati al nocciolo, alla sostanza, al centro di irradiazione di ciò che fu amore, desiderio, passione, estasi, perdita di sé nell’altro, comprensione profonda, fusione. E cosa ancora? Io ho una teoria e adesso la esporrò. Fra i rapporti sessuali possibili il primo, e più diffuso probabilmente, è quello tradizionale maschio‑femmina all’interno del la propria specie e, in genere, razza, banalmente destinato alla procreazione. Questo mi fa sbadigliare per prevedibilità e inorridire per volgarità. È capitato anche a me una volta con conseguente strascico di faticosa cucciolata e preferisco stendere un velo sulla foia miagolante che mi ha agguantata spegnendo nell’abbraccio brutale e penetrante ogni mia voglia. Il secondo tipo di esperienza m’interessa ancor meno. Riguarda anche questa esseri della stessa specie ma con una variante anticonformista e sterile. Le coppie maschio‑maschio e femmina‑femmina non è che raggiungano chissà quale grado superiore di conoscenza carnale. Gratta gratta somigliano tali e quali alle precedenti con in più un carico di luttuosa follia, di compiaciuta dannazione, di funebre e cannibalesco desiderio molto, molto distanti dalla radice naturalmente gioiosa della sensualità quale io l’ho conosciuta e praticata nella mia rapinosa esistenza. Ed eccoci dunque a quelle che io chiamo esperienze sessuali del terzo tipo e che colloco al livello più alto nella scala ideale dei valori amorosi. Si fanno queste esperienze nell’incontro incongruo fra due ‑ differenti regni, umano e animale, e si raggiungono le più imprevedibili, sofisticate vibrazioni emotive se ci si abbandona completamente alla novità senza ripetere le attività tipiche del primo e secondo tipo. Come spiegare ai rozzi frequentatori delle esperienze comuni l’universo illimitato delle carezze elettriche, delle scosse praniche, che ancora adesso al solo evocarle mi sollevano la pelliccia lungo la spina dorsale? t naturalmente al terzo tipo di incontro sensuale che appartiene la mia storia con lei, la cara donna bruna, dalle mani come ali di farfalla, dalle labbra come mattutino posarsi di rugiada. E il fatto che fossimo femmine entrambe non è certamente secondario in questa vicenda. Perché per le femmine ‑parlo delle femmine vere, delle tuttofemmine, non di quelle caricature checchesche, di quelle bambolone farsesche, di quelle maschere puttanesche che maschi senza stile hanno inventato e donne senza spirito imitato ‑ il sesso è qualcosa di languido ed estenuante, duraturo e carezzevole, abissale e originale, iniziatico e prismatico, artistico e spirituale, attivo e contemplativo, amichevole e mutevole, asciutto e fluviale, liturgico e sacrale. Per non dire di più. Per tacere l’indicibile. Insomma noi non ci incontravamo soltanto nei corpi, noi trovavamo ridicolo il meccanico bum‑bum dell’atto sessuale puro e semplice, necessario ma primitivo, piacevole ma ripetitivo. In noi l’incontro cominciava dagli occhi. Oh, mica superficiale incrociarsi di sguardi. Guardarci era scambiarci il colore degli occhi, era tuffarsi l’una nelle cellule sconvolte dell’altra, era approssimarsi all’incendiata sede dell’anima. Provate a convincere un maschio che tutto ciò è un’esperienza superiore, più intensa, erotica, sorprendente. Un maschio con le sue fantasie pornografiche, con il suo rosso da macelleria, giarrettiere nere e buchi dilatati in faccia. Che ne sa lui della verità femminile. Una femmina accetta di essere stuprata ogni volta dal maschio per compiere il suo dovere verso la natura che la vuole piena e feconda di tanto in tanto. Ma l’erotismo suo, la sensualità sua è un’altra cosa. t seta gattesca, è morbida impellicciata capriola, è stiracchiamento di una schiena contro l’altra, è ronfaggio di musi che si strofinano, è occhi che si chiudono a fessura fissandosi da vicino, da vicinissimo, da così vicino che non si vede più nulla se non il fondo azzurro, il fondo nero degli occhi dell’altra.
Lei mi chiamava Topazia, ma anche in molti altri modi. Mi chiamava Peppina per tirarmi giú dal trono di regina e subito dopo mi ci rimetteva offrendomi la corona di Principessa. Ero Pepeca non so perché e anche Topolina. Ero Mandarina, Zarina, Carotina. Ero dei derivati come Peppuccia, Pepè, Topinca. Per me lei era Lei soltanto, io la sentivo Lei ovunque e comunque, e Mia. Anche adesso che non può vedermi, ma sente la mia presenza e lascia che il libro che sta leggendo le scivoli sulle ginocchia e che lo sguardo nuoti nel nulla dell’aria e che la mente si svuoti per ritrovare solo la mia forma e la memoria di un momento, un episodio, un brandello della storia nostra. Io le sto leccando l’alluce con la mia lingua ruvida e insistente. Il piacere le fa chiudere gli occhi. Abbandona la gamba e le dita del piede si aprono come un ventaglio e io posso leccare fra dito e dito, mordicchiare il mignolo. Le faccio solletico, si scosta di scatto, apre gli occhi spaventata. Il ricordo le è sembrato realtà, così intenso. O forse intuisce che io sono qui, come una volta. Come una volta le salto in grembo, mi stendo ronfando, aspettando il lungo corso della sua carezza ripetuta mille volte dalla testa alla punta della coda, il tocco leggero, la fresca cavità del palmo. Brezza, rugiada. Fuoco. E nulla, nulla di sfinimento. Nulla di amoroso nulla. Quando l’universo, quello grande e lontano e quello vicino delle cose domestiche, familiari, si riduce alla sua percezione tu vedi una forma ed è soltanto il vedere, odi un suono ed è soltanto l’udire, annusi l’aria ed è soltanto un odore, mangi ed è soltanto sapore. Senza reazioni, senza rispondenze, senza distrazioni. Perché tutto è indifferente, tutto che non sia la sua carezza e il nostro amore.
Sospiro. Sono diventata molto vecchia, mentre lei conservava un giovanile vigore. Sedici anni per una donna sono una stagione, per un gatto una vita lunga. Nell’ultimo anno la mia bellezza è sfiorita, quasi da un giorno all’altro ho perso l’elasticità nel movimento, la forza nel salto, l’appetito. Non che l’amassi di meno, no. Ma non avevo l’energia dell’effusione, eppoi la mia mente era confusa, mi disturbavano pensieri ottenebranti. Passavo ore in un torpido dormiveglia abitato da ombre indecifrabili in cui di tanto in tanto mi raggiungeva il brivido elettrico di un suo abbraccio o di una sua parola. Lei continuava a chiamarmi Principessa, a risvegliare il mio amor proprio definendomi, come sempre, la più bella di tutti i gatti. E io alzavo la testa con un certo orgoglio e riuscivo ad aprire la bocca in un miagolio muto decifrabile a lei solamente, ma questo mi bastava, mi bastava ritrovarmi specchiata nell’arcobaleno delle lacrime che mi lasciava cadere sul pelo e che riuscivo talvolta a bere con uno sforzo segreto. Voleva tenermi in vita, trattenermi. Per questo quando io, richiamata da un misterioso istinto, m’incamminavo sonnambula sui tetti verso il vuoto, mi rincorreva e acciuffava svegliandomi dal mio sogno di tenebre. Io ritrovandola la riconoscevo e di nuovo l’amavo e dimenticavo per qualche giorno il buio gorgo verso cui mi stavo avviando.
Nel giorno del suo compleanno c’erano fiori nei vasi e si preparava una festa. Era distratta, affaccendata. Non aveva chiuso la finestra. Avevo ritrovato la lucidità per salutarla. Al mattino di nuovo, dopo tanto tempo, le ero saltata in braccio, c’eravamo guardate negli occhi e le sue carezze si erano susseguite come onde di mare sul mio corpo. Un calmo agitarsi della coda le diceva che ero presente, la rassicurava. Sono stata perfettamente felice, le ho posato un bacio sulla mano, ho socchiuso gli occhi con quel che restava di azzurro in essi. L’ho vista sorridere sollevata. Poi sono andata a dormire. Poi non vista sono uscita sul terrazzo. Mi sono affacciata. Il vuoto non mi ha respinto. Il vuoto era il tutto, vera forma delle cose, rappresentazione fedele della mente. Anch’io non ero più 10, ero il vuoto. Non riconoscevo più nulla di mio e lei era scomparsa in quel vuoto, anzi anche lei era il vuoto. Dovevo scivolare e avrei avuto tutto in un unico istante, me stessa che non ero più, lei che era il vuoto, il vuoto stesso che era tutto. Oscillai. Non per paura, ma perché ormai ero in balia del vento e di una spinta che non apparteneva a me. Non avrei potuto buttarmi nel vuoto semplicemente perché non c’era più un io a decidere e non c’era un vuoto a ricevermi. Io già volteggiavo in quel nulla‑tutto, mi cullavo nella beatitudine del volo. Certo lei deve aver gridato. Deve aver interpretato la scena come suicidio o precipizio. Il suo senso dello spazio le fa giudicare i dislivelli nel senso di alto e di basso, di salita e di discesa. La sua percezione le indica la caduta, il tonfo. Per lei c’è il cielo e c’è la terra, c’è il pieno dell’aria, c’è la vita e c’è la morte. Come spiegarle?
Ma non è necessario spiegare niente. È qui col suo ricordo. Più passa il tempo e più si avvicina al vero, sa di non appartenersi, si lascia invadere da me, dal vuoto che io sono adesso. Ha cominciato a soffrire di vertigini, spesso è vittima di mancamenti. Dice: ho paura del vuoto e dell’altezza. All’inizio è cosi. Poi la paura si trasforma in attrazione. Il resto diventa indifferente, si perde la percezione del confine, del limite. Il sé si libera del corpo e poi si libera anche di se stesso, si svuota e risuona vuoto, niente lo tocca o lo commuove, niente gli importa che non sia la sua centralità vuota nel centro del vuoto. lo sono in questo centro e sto per coincidere con lei, quando anche lei lascerà le mani che la trattengono e il suo passo non avrà più suono. Il nostro attrarci e capirci oltre le diverse forme corporee, i regni di riferimento, la sciocchezza delle classificazioni, era un segnale. Noi lo sapevamo fin dall’inizio. Eravamo una creatura sola pronta a fondersi con se stessa. È solo questione di tempo, poi anche lei seguirà l’istinto.