Samuel Beckett attraverso le lettere (Il Foglio 25/2/12)
 Samuel Beckett è uno di quegli autori, come Kafka, come Joyce e, più recentemente, Thomas Bernhard e forse anche un po’ Elsa Morante, che non generano solo lettori, ma adoratori. La stima si trasforma in culto. Così adesso l’uscita dei primi due volumoni di lettere sui quattro previsti che copriranno tutta l’attività di scrittura dal 1929 al 1989, vale a dire da quando comincia a pubblicare le prime poesie alla morte, è il grande evento della cultura mondiale, soprattutto anglofona visto che l’ambizioso progetto, The Letters of Samuel Beckett, lo si deve alla Cambridge University Press per la cura di Martha Dow Fehsenfeld, oggi ottantaquattrenne, con l’aiuto di altri tre studiosi.
Samuel Beckett è uno di quegli autori, come Kafka, come Joyce e, più recentemente, Thomas Bernhard e forse anche un po’ Elsa Morante, che non generano solo lettori, ma adoratori. La stima si trasforma in culto. Così adesso l’uscita dei primi due volumoni di lettere sui quattro previsti che copriranno tutta l’attività di scrittura dal 1929 al 1989, vale a dire da quando comincia a pubblicare le prime poesie alla morte, è il grande evento della cultura mondiale, soprattutto anglofona visto che l’ambizioso progetto, The Letters of Samuel Beckett, lo si deve alla Cambridge University Press per la cura di Martha Dow Fehsenfeld, oggi ottantaquattrenne, con l’aiuto di altri tre studiosi.
Sono famosi i lunghi silenzi, le invalicabili riservatezze di Beckett, che però aveva un debole per le donne cui difficilmente sapeva dire di no, e le lettere sono lì a dimostrarlo. Detestava che qualcuno frugasse nella sua vita, ma non ostacolò nel 1971 la giovane americana Deirdre Bair autrice della prima biografia, parziale, su di lui, che uscì nel ’78 e in Italia, per Garzanti, nel ’90. Così come nel 1950 aveva spalancato la porta proprio a Martha Fehsenfeld – lui era un atletico quarantaquattrenne – inviata a Parigi da un lungimirante professore della New York University per «stanarlo». «Marthy» sarebbe diventata negli anni uno dei più importanti studiosi del teatro beckettiano, nonché cara amica. Così l’autore di Aspettando Godot telefonò a lei un giorno del 1985 per consegnarle gli scatoloni pieni di oltre 15000 lettere e incaricarla ufficialmente di curare il suo epistolario, pur chiedendole di limitarsi «alla parte che riguarda il lavoro». Ma tre anni dopo il vecchio irlandese toglieva il disturbo e le sue volontà furono fortunatamente disattese, come è probabile avesse messo in conto.
Nel 1928 si era trasferito a Parigi scappando dalla detestata Dublino per rompere il legame di amore-odio che lo legava a una madre, May, estremamente possessiva. A Parigi conosce James Joyce, che ha con la nevrotica figlia Lucia un rapporto altrettanto complicato. L’attraente viziata Lucia, coetanea di Sam, se ne innamora, ma nella testa di lui è solo un ostacolo all’amicizia col padre e così – gli successe di rado nella vita – con la ragazza sarà durissimo: la respinge senza mezzi termini, involontariamente la umilia. Fine del rapporto con Joyce e fiume di lettere all’amico di college Thomas McGreevy, che li aveva presentati, resoconto della sua infinita tristezza, degli innumerevoli sintomi nevrotici: bubboni deturpanti, insonnie e soprattutto l’incrudelirsi di ataviche insicurezze. Si dichiara in continuazione «verbalmente costipato» laddove la divinità Joyce, suo modello irraggiungibile, sapeva scrivere con naturale scioltezza. Ma erano in definitiva due scrittori molto distanti: Beckett aveva bisogno di un controllo totale sulle parole che si sarebbero ridotte al minimo, all’essenziale, addirittura al non-dire, mentre «la scrittura di Joyce – spiega all’amico Tom – non è un componimento su qualcosa, è quel qualcosa». Un giorno Joyce gli stava dettando un racconto, come succedeva spesso perché i problemi alla vista si erano aggravati. Qualcuno aveva bussato alla porta, Joyce aveva detto: «Avanti». Rileggendo il brano alla fine, era uscita fuori quella parola che non c’entrava niente col testo. Ma l’autore di Ulisse aveva deciso di conservarla, perché per lui «il caso era un ottimo collaboratore». E questo per il costipato Beckett era inconcepibile.
«Sai, non riesco più a scrivere» si dispera in un’altra lettera a McGreevy. «La più semplice frase diventa una tortura». Quando sta per concludere il suo primo romanzo, Murphy, si lamenta: «Dormo malissimo, per colpa del libro immagino. Quanto è difficile raggiungere un compromesso tollerabile fra lavoro e vita». Niente, rispetto alla sequela di sintomi che gli descriveva qualche anno prima, fra il ’33 e il ’35, da Londra, dove era andato a farsi curare alla Tavistock Clinic da un giovane genio della psicanalisi junghiana, il creativo, eretico Wilfred Bion: «palpitazioni, sudori notturni, tremito, panico, senso di soffocamento e, negli attacchi più gravi, paralisi totale». Fu Bion a mettere a fuoco con lui la «peterpanite» – così la definì Beckett stesso – e il ruolo nella sua buia infelicità della madre richiestiva, fredda, oppressiva, che però finanziava il figlio nullafacente per permettergli quella terapia. E fu sicuramente Bion a incoraggiarlo a scrivere, come alternativa al suicidio che l’aspirante artista corteggiava fin dall’infanzia.
Da piccolo, nel giardino di casa, faceva un gioco pericoloso. Saliva sul più alto dei pini e si lanciava nel vuoto, aggrappandosi a un ramo basso appena in tempo per non schiantarsi al suolo. Esistono ancora quella casa e quel giardino: Cooldrinagh House, nome gaelico che vuol dire «retro della siepe di prugnolo», in Kerrymount Avenue a Foxrock, sobborgo elegante a sud di Dublino. C’è una targa blu a ricordare che lì nacque il 13 aprile del 1906 il Premio Nobel per la Letteratura del 1969. I nuovi inquilini sono obbligati per contratto ad accogliere i (rari) visitatori. Scovare il posto è piuttosto complicato. Dublino ha trasformato in museo ogni casa in cui Joyce ha vissuto anche solo quindici giorni, ma non coltiva un analogo culto per Beckett che del resto definiva la sua città «asfissiante, provinciale» e punì «la mentalità ristretta» del suo paese proibendovi la rappresentazione, finché era in vita, delle sue opere teatrali. Nel giardino di pini ce ne sono tanti, e tutti giganteschi, e c’è il campo da tennis dove Sam e suo fratello Frank, adolescenti, s’impegnavano in estenuanti partite. All’interno del bel villino vittoriano, tutto bianco, le vestigia beckettiane non sono molte: la luminosa stanza con grande bovindo dove è nato, un ritratto, le tacche sul muro per misurare la crescita dei due ragazzini, le firme che il giovane Sam andava incidendo sulle pareti nei momenti di noia; facevano infuriare la severa May, ma per quanto riverniciasse, sono sempre lì. Dalle finestre, oltre i campi di golf che allora non esistevano, si vedono, verdi e disabitate come un tempo, le colline dove lo portava a camminare il padre: «avrei voluto che mi prendesse in braccio, ma non ci pensava proprio» (La fine). Era un padre spartano, Bill Beckett. Portava i figli al Forty Foot, un posto di Dublino ricordato nell’Ulisse, dai cui scogli gli uomini coraggiosi si tuffavano. Per insegnare ai bambini a nuotare li gettò nell’acqua senza smancerie. Diventarono nuotatori abilissimi. Sam continuò anche da grande a tuffarsi, estate e inverno, nelle baie della città. Il posto che preferiva era il suggestivo braccio di mare sotto la collina di Howth, un luogo finale, impressionante, spazzato da venti gelidi dove s’incontrano pochi passanti e i pub sono pieni di marinai.
Era l’epoca in cui frequentava senza grandi risultati il Trinity College, s’innamorava di una studentessa civetta che non lo ricambiava, perché malgrado la «straordinaria bellezza» era molto impacciato e aveva fama di matto. Non gli era passata l’attrazione per i giochi spericolati. Per dirne uno, lanciava le moto a folle velocità e spesso le distruggeva in incidenti da cui usciva miracolosamente indenne. Non aveva niente dell’intellettuale. «Per anni sono stato infelice, consapevolmente e deliberatamente» scrive al solito McGreevy mentre è in terapia con Bion. «M’isolai sempre più, m’impegnai sempre meno e mi abbandonai a un crescendo di disprezzo per gli altri e per me stesso… Finché quel modo di vivere, o forse piuttosto quella negazione del vivere, non sviluppò sintomi fisici così spaventosi da non permettermi più di andare avanti… Insomma se il cuore non avesse messo la paura di morire dentro di me, io sarei ancora lì a ubriacarmi, ghignare e andare a giro pensando di essere troppo in gamba per fare qualsiasi altra cosa». Era l’inizio della consapevolezza di sé, il successo dell’analisi che da ragazzo scapestrato e passionale lo trasformava poco a poco nell’uomo solitario e generoso, vulnerabile, buono con le persone ammalate, i vecchi, gli animali e che spesso ha sofferto e fatto soffrire gli altri, le donne soprattutto, proprio per il terrore nevrotico di fare del male.
Per un anno intero tenne nascosta a tutti l’esistenza di Suzanne Deschevaux-Dumesnil, una pianista trentasettenne con cui aveva giocato a tennis dieci anni prima, rincontrata nel ’38 mentre era impelagato in una bollente relazione con l’ereditiera americana Peggy Guggenheim (che poi avrebbe raccontato nelle sue memorie di essere stata «completamente ossessionata per un anno da quella strana creatura, Samuel Beckett»). Ne parla a Tom solo nel ’39: «C’è anche una ragazza francese cui voglio bene, non è una passione. E’ molto buona con me. Non ci scommettiamo perché tutti e due sappiamo che finirà, non si può sapere quanto durerà». Durò tutta la vita. Suzanne prese il posto di May, ma una May che lo rispettava, lo proteggeva dal resto del mondo e tollerava con una certa superiorità i molti tradimenti. Fino a quando, nel ’60, entrò nella vita di Sam Barbara Bray, redattrice della Bbc a Londra, vedova con due figlie piccole, destinata a una relazione parallela stabile che durò per il resto delle loro esistenze. Quando dopo un anno Barbara lo informò che voleva trasferirsi a Parigi, la reazione di Sam fu tipicamente beckettiana: sposò Suzanne, con cui conviveva da un ventennio, e aiutò Barbara a sistemarsi nella capitale francese. «Per non fare soffrire nessuna delle due» chiosarono gli amici. Quando poi nel luglio dell’89 Suzanne morì, Sam ebbe un crollo violento e cominciò a essere divorato dai sensi di colpa. Le sopravvisse nemmeno cinque mesi.
«Bere il caffè senza il brandy» definiva fare l’amore senza essere innamorati. Ma quanto durava l’innamoramento? Aveva scritto una poesia alla fine degli anni Trenta, in quel periodo particolarmente affollato di donne: «vengono/ diverse e le stesse/ con ciascuna è diverso e lo stesso/ con ciascuna l’assenza d’amore è diversa/ con ciascuna l’assenza d’amore è la stessa».
 «Che tipo era? Credo che esistano due Beckett. Quello pubblico e mio zio Sam» mi ha raccontato Caroline Beckett, sposata Murphy, la figlia di Frank, quando l’ho conosciuta alla fine del ’90. «Zio Sam era una persona simpatica e tenera in cui la maggior parte della gente stenterebbe a riconoscere lo scostante, ombroso scrittore». Caroline abitava a Shottery, nella zona residenziale di Killiney a sud di Dublino, nella casa ereditata dal padre: una villetta nascosta in fondo a un’invisibile via privata, sepolta nel verde. Il soggiorno austero, con le credenze e il tavolo centrale, era la stanza preferita dallo zio. «Si sedeva nella veranda e guardava i colori accesi del giardino, il mare in lontananza». Lo stagno l’aveva costruito proprio lui, con le sue mani. Era il 1954. Alla fine di aprile Beckett a Parigi fu raggiunto dalla notizia che il tumore ai polmoni di Frank era arrivato alla fase terminale. Tornò immediatamente a Dublino e si sistemò a Shottery per tutta l’estate fino alla metà di settembre, quando Frank morì. Toccò a Sam rivelare al fratello la verità sulle sue condizioni; e fu ancora Sam ad accudirlo negli atroci ultimi momenti. Quattro anni prima per l’agonia della madre non aveva avuto la stessa forza. Era andato a passeggiare lungo il Grand Canal e tornando verso l’ospedale aveva visto abbassarsi la tapparella della stanza di May, segno che era spirata. Poi avrebbe ricordato la scena nell’Ultimo nastro di Krapp. L’idea dello stagno era stata una delle sue trovate per distrarre il malato. «Mio padre aveva sempre desiderato avere in giardino un piccolo stagno con le ninfee e così zio Sam volle farglielo. Ma l’ingegnere era mio padre e perciò, seduto sotto un albero, battendo in terra il bastone, lo guidava passo passo».
«Che tipo era? Credo che esistano due Beckett. Quello pubblico e mio zio Sam» mi ha raccontato Caroline Beckett, sposata Murphy, la figlia di Frank, quando l’ho conosciuta alla fine del ’90. «Zio Sam era una persona simpatica e tenera in cui la maggior parte della gente stenterebbe a riconoscere lo scostante, ombroso scrittore». Caroline abitava a Shottery, nella zona residenziale di Killiney a sud di Dublino, nella casa ereditata dal padre: una villetta nascosta in fondo a un’invisibile via privata, sepolta nel verde. Il soggiorno austero, con le credenze e il tavolo centrale, era la stanza preferita dallo zio. «Si sedeva nella veranda e guardava i colori accesi del giardino, il mare in lontananza». Lo stagno l’aveva costruito proprio lui, con le sue mani. Era il 1954. Alla fine di aprile Beckett a Parigi fu raggiunto dalla notizia che il tumore ai polmoni di Frank era arrivato alla fase terminale. Tornò immediatamente a Dublino e si sistemò a Shottery per tutta l’estate fino alla metà di settembre, quando Frank morì. Toccò a Sam rivelare al fratello la verità sulle sue condizioni; e fu ancora Sam ad accudirlo negli atroci ultimi momenti. Quattro anni prima per l’agonia della madre non aveva avuto la stessa forza. Era andato a passeggiare lungo il Grand Canal e tornando verso l’ospedale aveva visto abbassarsi la tapparella della stanza di May, segno che era spirata. Poi avrebbe ricordato la scena nell’Ultimo nastro di Krapp. L’idea dello stagno era stata una delle sue trovate per distrarre il malato. «Mio padre aveva sempre desiderato avere in giardino un piccolo stagno con le ninfee e così zio Sam volle farglielo. Ma l’ingegnere era mio padre e perciò, seduto sotto un albero, battendo in terra il bastone, lo guidava passo passo».
L’anno precedente Beckett aveva conosciuto a Parigi una trentaduenne americana, Pamela Mitchell, che doveva comprare i diritti di Aspettando Godot in qualità di amministratore finanziario per una produzione newyorkese. Lui la chiamava Mouki. «Devi volermi bene, ma non troppo bene, non ne vale la pena, finiresti col soffrire, non mi conosci» l’aveva avvertita. E dalla casa del fratello, nella più profonda prostrazione («la parola felicità non ha più nessun senso per me») continuava a scriverle e a lasciarla dicendo che non voleva farle del male. La rivide a Parigi dopo la morte di Frank e quando lei, esasperata, tornò definitivamente a New York lui le scrisse: «… giocheremmo a parole incrociate, di tanto in tanto, e ogni sei ore tu m’imboccheresti con un hamburger e l’ammazzapianista. No? Sì? Esatto». Continuarono a scriversi e a vedersi sporadicamente e clandestinamente per diciassette anni.
«Una delle tante contraddizioni di Samuel Beckett era di amare moltissimo leggere biografie, ma negare la presenza di accenni autobiografici nella propria opera, che invece ne è piena» dice il suo biografo più accreditato, e amico ventennale, James Knowlson autore di Damned to Fame. The Life of Samuel Beckett, uscito nel 1996 e tradotto da Einaudi nel 2001. «Nell’ultimo anno di vita lesse le biografie di Oscar Wilde, di Nora Joyce e di Jack Yeats». Era l’88. Si trovava, dopo una caduta in cucina, come un vecchio qualsiasi in una modesta casa di riposo per rimettersi e fare fisioterapia, a pochi passi dal suo appartamento in Boulevard Saint-Jacques, dove Suzanne, anche lei parecchio malmessa, era diventata sempre più irritabile e ostile, particolarmente con lui. «E come è meglio alla fine fatica perduta e silenzio. E tu come sei sempre stato. Solo» (Compagnia). Riusciva ancora a lavorare traducendo da sé dall’inglese al francese Stirring still e dal francese in inglese Comment dire che Barbara gli batteva e stampava al computer (tutti e due i testi sono compresi nel volume einaudiano In nessun modo ancora). Poi alternò momenti di lucidità angosciata a momenti di oblio finché, come aveva scritto tanti anni prima nel romanzo Malone muore: «Voilà, jamais. Voilà plus rien».
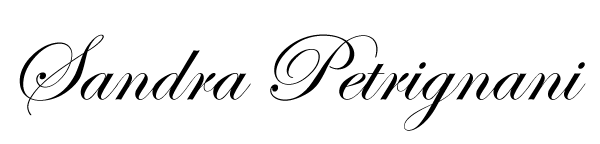




guido villa
Molto interessante!