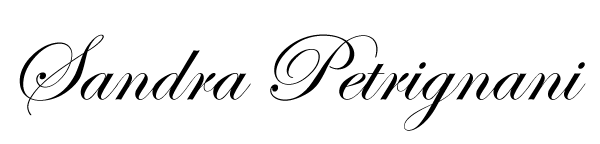“Camera con vista”, la mia rubrica su Moby Dick (Liberal, 16/4/11)
Gli editori non amano i libri di racconti, vogliono romanzi. E pazienza se poi i romanzi, in grandissima parte, non sono che racconti dilatati, e quindi romanzi sbagliati. Perché un romanzo è qualcosa di diverso da un racconto. Il primo ha una costruzione complessa, personaggi che evolvono nel corso della storia, un intreccio con un certo numero di sorprese e cambiamenti (psicologici, esistenziali, temporali). Nel racconto è essenziale un punto focale, perché centrale è il dettaglio. Detto altrimenti: il racconto va in profondità, è verticale; mentre il romanzo è prevalentemente orizzontale. La morte di Ivan Il’ič, per esempio, non è un romanzo, anche se gli editori si affannano a presentarlo come tale e anche se è abbastanza lungo perché i lettori abbiano l’illusione di aver letto un romanzo. Ma cos’è questo dettaglio illuminato dal racconto? E’ il perturbante della vita. Nel caso di Ivan Il’ič è la morte in persona. Un racconto riuscito mette a fuoco una crisi, una crepa nello scorrere liscio dei giorni.
Sembra un discorso che lascia il tempo che trova, ma non è così, viste le difficoltà che i libri di racconti hanno ad entrare in libreria, ammesso che riescano a superare lo scoglio editoriale. Il pubblico non li vuole, è la giustificazione. Quale pubblico, mi viene da chiedere. Quello che si contenta dell’ultimo libricino – targato romanzo – di un ennesimo esordiente? Ma dove andranno a parare tutti questi esordienti, autori spesso di un solo libro, destinati a non tirare fuori l’opera numero due? Questa, però, è un’altra storia. Torniamo ai racconti e, in particolare, a quelli che ha scritto Patrizia Zappa Mulas per et al. /edizioni, con il bel titolo Purché una luce sia accesa nella notte. Sono quattro in tutto e la bandella di copertina si affretta ad avvertire l’eventuale acquirente che si tratta «forse di quattro capitoli sparsi di un romanzo nascosto», a proposito di quanto andavamo dicendo prima. Ma non importa. Siano o no capitoli di un romanzo a venire, quel che conta è che sono racconti molto belli, capaci di mettere a fuoco uno stato d’animo incerto e perturbante.
Tre di essi sono ambientati a Milano, una Milano insolita, una Milano «che fa ombra troppo presto sui palazzi inghiottiti dal buio», perché poche sono le finestre delle case illuminate in una città dove la gente sta tanto in ufficio. Una Milano vista con gli occhi di una bambina che si sente «diventare grande» (S. Siro) e poi lo diventa e studia danza (Piazza Fontana) e le sue ambizioni si scontrano con la violenza incomprensibile di una bomba e la ragazza capisce che non potrà sopravvivere «in quella devozione muscolare esclusiva». Eppure è ancora e sempre il corpo che trionfa nella scalata al vulcano del racconto Stromboli, dove la forza d’animo si misura nella resistenza fisica e nel conclusivo Via Solferino, raccontato da un punto di vista maschile, ma dove l’ex bambina ballerina torna come antico amore del protagonista, amore mai superato «perché niente era mai passato». Neanche la giovinezza, se alla sua forma fantasmatica si oppone la volontà di vivere e di essere felici dell’età adulta. Patrizia Zappa Mulas è un’attrice teatrale di riconosciuto talento. Ma è anche scrittrice di rari romanzi (L’orgogliosa e Rosa furia, pubblicati dalla Tartaruga) e del racconto Tigre adorata (nottetempo). E’ la generosa curatrice dell’opera omnia di Alice Ceresa e di alcuni testi di Franca Valeri. La sua scrittura è nitida, corporea: riesce a far passare un’impostazione raziocinante della vita (ha fatto studi filosofici) dentro la fisicità di corpi che s’incontrano e scontrano, che combattono lotte – anche spirituali – con se stessi, si attrezzano per parare i colpi del destino e, a volte, battagliano (vincendo) contro di essi.
In un recente viaggio che ho fatto a Berlino, è stato un libro di racconti la mia guida, di una scrittrice tedesca che avevo conosciuto e dimenticata senza mai leggerla. Avevo fatto molto male, ma i libri sanno trovare da soli la loro strada e ci cadono nelle mani quando ne abbiamo bisogno. La scrittrice è Monika Maron, nata a Berlino est nel ’41 e poi domiciliata nella parte ovest della città. Il libro, La mia Berlino, è stato tradotto nel 2005 da Bollati Boringhieri (72 pagine, 14 euro); malgrado i tempi che corrono, in cui i bei libri non strombazzati da uffici stampa aggressivi e giornalisti culturali suggestionabili spariscono nel giro di poche settimane dalle librerie, si può ancora trovare previa ordinazione. Dai brevi testi autobiografici della Maron ho capito un sacco di cose sulla città e sui suoi abitanti che in nessuna delle mie numerose visite, prima e dopo la caduta del Muro, avevo colto. Una per tutte: è evidente anche a un turista distratto che ai berlinesi piacciono i cani. Ne possiedono molti più che in ogni altro posto e li portano a passeggio sotto la neve come sotto l’acqua con sorridente consuetudine. Ma perché improvvisamente ora gli amati quattrozampe sono tutti al guinzaglio? Era così amichevole vederli scorrazzare liberi per la città, in qualsiasi quartiere e a qualsiasi ora. Beh, la Maron ce lo spiega, dopo aver dato questa stravagante spiegazione del legame fra berlinesi e cani: «E’ anche possibile naturalmente che la parlata berlinese, che spesso, per il tono a tratti abbaiante, porta a non capirsi nelle relazioni con altri ceppi tedeschi, sia particolarmente adatta a comunicare coi cani». Ma insomma, ammette, «esiste a Berlino anche una decisa frangia di persone che li odia, specializzate soprattutto nel combattere la cacca…». Ecco, questa bellicosa minoranza ha vinto e adesso «tutti i cani berlinesi, anche il terrier della mia vicina, dalle dimensioni di una scarpetta, devono essere tenuti al guinzaglio». Non posso che associarmi alla sua finale considerazione: «i nemici dei cani e quelli dei fumatori non solo perseguitano con analogo furore i loro avversari, ma paiono ugualmente ossessionati dal ritenere che un mondo privo di fumatori e di cani sarebbe finalmente un mondo pulito, felice e pacificato».
E dato che abbiamo difeso i fumatori, mi viene in mente Eugenio Baroncelli, autore di eccentrici racconti pubblicati con Sellerio. Cito dal Libro di candele. 267 vite in due o tre pose il capitoletto dedicato ad Anton Webern, che comincia così: «Certo che il fumo uccide». Webern fu impallinato nel ’45 da un soldato americano perché, incurante del coprifuoco, era uscito sul balcone a fumarsi un sigaro, che brillava nella notte.